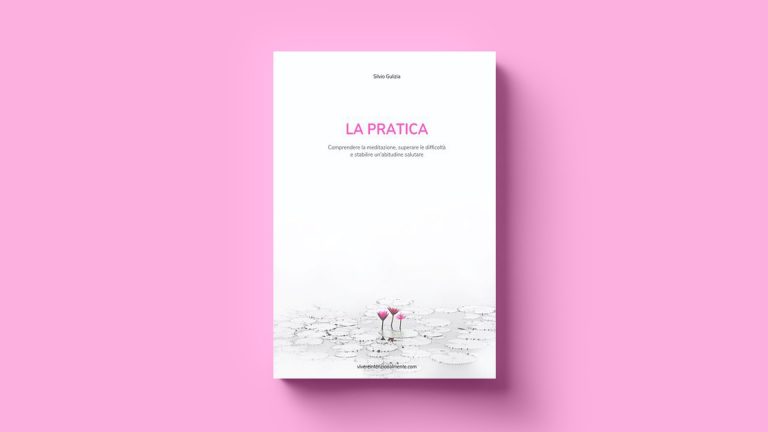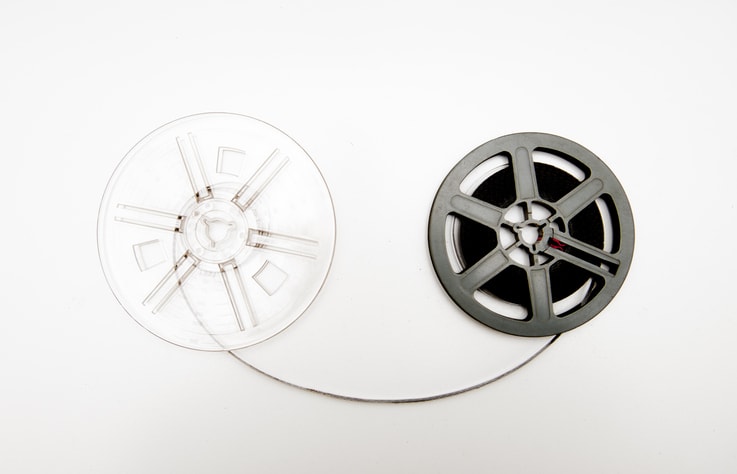

L'amore per il cinema è un valore positivo per la nostra vita di tutti i giorni

Che cosa ci fanno centinaia di persone ordinatamente in fila, con zainetti e mani in tasca, fuori da una sala cinematografica in attesa di vedere un film che comincia un’ora dopo? No, non è uscito il nuovo film di Checco Zalone né il finale della nuova trilogia di Star Wars, anzi è probabile che questa folla si accinga a guardare una pellicola islandese in lingua originale con sottotitoli italiani o un film tunisino recitato in francese o qualche altra bizzarra combinazione.
Queste scene si presentano regolarmente se andate a un festival di cinema. Venezia, Cannes, Berlino, ma anche Torino, Bologna, Firenze, c’è solo l’imbarazzo della scelta. È stato calcolato che se un appassionato se lo potesse permettere potrebbe seguire un festival a settimana per tutto l’anno senza mai tornare a casa, viaggiando in tutto il mondo.
Tuttavia: d’accordo il piacere di guardare film, ma che cosa spinge a sacrifici così importanti? La risposta è univoca: la cinefilia. La passione per il cinema può essere divorante quanto la melomania, la bibliofilia, la fashion addiction, anche se ha caratteristiche proprie.
Per esempio:
- Il cinefilo considera la fila in piedi, il sacrificio, il viaggio, la fatica come ostacoli da superare per meritarsi la proiezione
- Il cinefilo si circonda di cinefili
- Il cinefilo detesta chi parla di cinema senza saperne abbastanza
- Il cinefilo ama i film minori che gli altri hanno scartato snobisticamente
La cinefilia, però, si è man mano alleggerita, democratizzata. E oggi – complice la condivisione delle proprie passioni sui social network – i cinefili sono aumentati e ringiovaniti, alla faccia di chi dice che la settima arte è in crisi. Anche senza vivere a Parigi, dove chi non è un cinefilo è considerato un tipo poco raccomandabile, si può cioè entrare nella comunità degli amanti assoluti del cinema.
Il passo successivo, una volta identificato il fenomeno, è però chiedersi se la cinefilia possa essere considerata anche un valore positivo per la nostra vita di tutti i giorni. Ebbene, ci sono almeno due aspetti che fanno propendere per questa ipotesi:
- La cinefilia offre forme di emancipazione dai problemi quotidiani anche i più gravi. La storia della passione per il cinema è piena di racconti di vita che narrano di come singole persone – schiacciate da pregiudizi, disagi sociali, impedimenti fisici, drammi civili e politici, fragilità psicologiche – abbiano trovato nei film e nella cultura cinematografica un luogo di riscatto emotivo e di rinascita personale. Si sono, cioè, sentite se stesse di fronte allo schermo e hanno ritrovato motivazioni importanti vedendo raccontati tutte le storie e tutti i personaggi immaginabili. Il cinema è sempre stato un modello di conoscenza e uno sprone.
- La cinefilia produce benessere in tutti noi. Anche andare semplicemente al cinema ogni tanto può farlo, ma la cinefilia – ovvero la frequentazione consapevole e assidua dei film, in sala e a casa – allarga le proprie conoscenze, mette in contatto gli appassionati, produce vantaggi cognitivi. Sono ormai molti gli studi scientifici (e non solo sociologici) che confermano questo aspetto di socialità e di condivisione favorita dalla cinefilia e dai film, come dimostrano alcune recenti scoperte riguardanti la mente degli spettatori e legate al tema dei neuroni-specchio. Ciò conferma l’assoluta originalità del cinema – rispetto agli altri mezzi espressivi – nel fornire modelli di vita ed esempi di esperienza per gli spettatori.
Quando, negli anni Cinquanta del secolo scorso, alcuni intellettuali e critici francesi resero la cinefilia un vero e proprio must culturale forse non immaginavano che una battagli artistica (quella per la legittimazione del cinema) si sarebbe trasformata in un processo di miglioramento di sé stessi e della società. Tant’è: il cinefilo, quello vero, non potrà che avere mente aperta e assenza di pregiudizi, perché amare i film significa apprezzare e riconoscersi in tutte le identità e in tutti gli universi possibili.