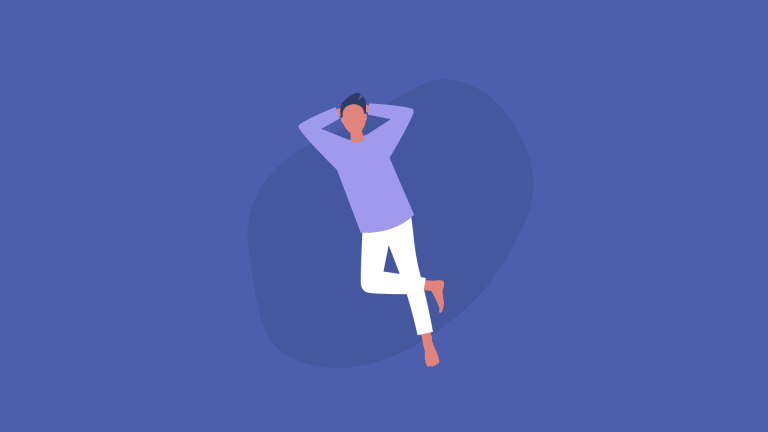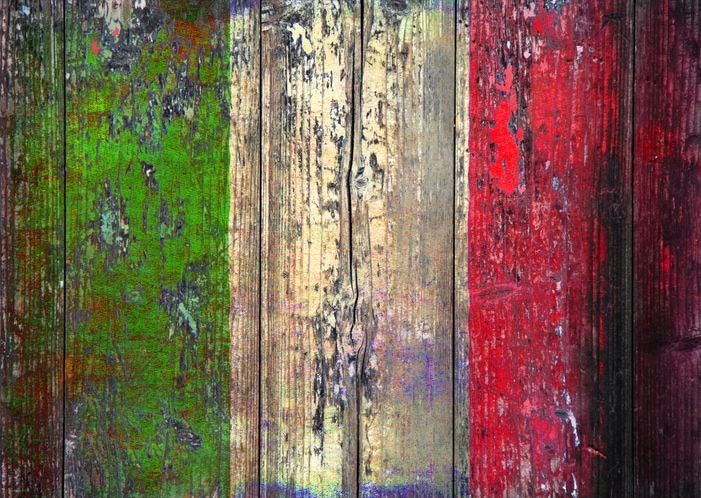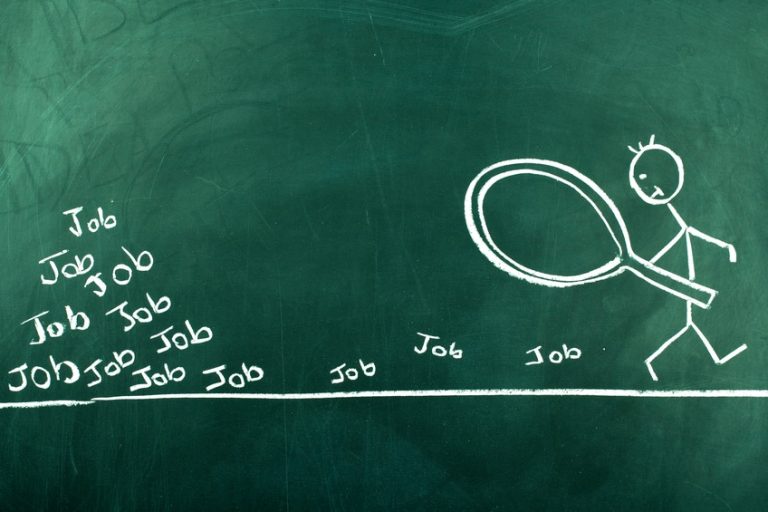Basta bufale: informarsi online è semplice, se sai come farlo

Internet ci rende stupidi? La rete è diventata un insieme banale e ridondante d’informazioni senza senso sulle quali non vale la pena investire del tempo? È vero che il web sta tirando fuori il peggio di noi tra ignoranza, mediocrità e aggressività più o meno repressa?
Non sono poche le ricerche e i titoli di giornale che, negli ultimi mesi e anni, hanno affrontato il fenomeno: dagli articoli di Nicolas Carr, il primo pubblicato addirittura nel 2008 e ripreso poi nel volume che gli ha permesso di vincere il premio Pulitzer, alle provocazioni di qualche anno fa di Umberto Eco. A rafforzare il concetto sono – più di recente – arrivate altre considerazioni su come internet ci stia rendendo, non solo meno intelligenti, ma anche maggiormente aggressivi. Ne sono un esempio le testimonianze del sociologo Richard Sennet e quanto – più di recente ancora – è successo con la ragazza sopravvissuta alla tragedia di Rigopiano.
Come si legge in questi articoli, Internet ha innescato un meccanismo psicologico di de-individuazione in cui ci sentiamo maggiormente tutelati dal poter fare quello che vogliamo senza aspettarci conseguenze. Questo tipo di meccanismo si traduce in due comportamenti principali: il primo riguarda la leggerezza con la quale ci informiamo e andiamo a fondo delle questione e il secondo la facilità con cui formiamo un’opinione e una critica ancora prima di aver conosciuto gli elementi in gioco.
Gli stessi social media sono pensati in questa direzione.
Pensate all’algoritmo di Facebook: la piattaforma sulla quale – in media – spendiamo la maggior parte del nostro tempo online. Il Newsfeed è costruito proprio secondo questo principio: continuerete a vedere notizie dalle persone alla quale mettete like o delle quali apprezzate gli aggiornamenti di stato. Un meccanismo che si auto-conferma all’infinito finendo per escludere altre possibili variabili dall’equazione e appiattendo – di fatto – il livello del dibattito. Si tratta di un fenomeno noto a chi studia psicologia chiamato bias di conferma, molto in breve: tendiamo a credere e ricercare maggiormente ciò che conferma le ipotesi e le conoscenze che già abbiamo.
Accanto a tutto questo, giungono sul mercato una serie di nuovi settori e di nuove tecnologie (internet delle cose, industria 4.0, fintech…) che richiedono di rimanere sempre più aggiornati e sempre più informati per capire cosa stia succedendo al mondo nel quale viviamo. Non è un caso che l’Economist abbia dedicato qualche settimana fa uno speciale sul long life learning e sull’importanza – economica, individuale e organizzativa – di mantenere uno standard informativo e formativo di livello lungo tutto l’arco della propria vita.
Come possiamo fare – quindi – per muoverci in questo scenario e per rimanere aggiornati evitando di perdere in qualità dell’informazione?
Le soluzioni ci sono e, a mio avviso, sono riassumibili in una serie di punti di attenzione che vanno tenuti ben presente e che richiedono un minimo di sforzo collaborativo per essere attuati. Vediamone alcune insieme:
– Aumentare il proprio livello di consapevolezza e di spirito critico: le bufale che spopolano su Facebook in questo momento sono – spesso – facilmente riconoscibili e anche quando non lo sono, partite sempre dal presupposto di verificare tutto quello che leggete. È semplice: copiate il contenuto su Google e scoprirete immediatamente se la notizia è vera o meno. La buona nuova è che Facebook stessa starebbe correndo ai ripari per arginare il fenomeno di diffusione delle notizie false.
– Verificare le informazioni è il primo punto, ma selezionare le fonti è altrettanto importante: costruire un network affidabile è sicuramente un passo decisivo che vi permette di circondarvi di informazioni di qualità.
– La qualità paga sempre: ed è anche – sempre – riconoscibile. Se è vero – come sottolineato dalle ricerche – che in rete non esiste la corporeità e tutto è maggiormente etereo, è altrettanto vero che le tracce digitali di quello che facciamo sono sempre identificabili (anche a distanza di anni): vale la pena porre una doppia attenzione a quello che diciamo e a quello che facciamo in rete.
– Rimanere sempre in uno stato di apprendimento continuo: in rete, dall’epoca del 2.0 ad oggi, si è sempre parlato di perpetual beta, nella filosofia orientale di shoshin (lo spirito del principiante). Due concetti differenti che sottintendono quanto espresso dal numero dell’Economist: l’importanza di mantenersi sempre informati e sempre in uno stato di apprendimento costante durante tutto l’arco della propria vita.
– Diffidare dei numeri, o meglio diffidare da chi utilizza il numero di utenti di un servizio per testimoniarne l’efficacia: purtroppo la quantità non è sinonimo di qualità men che meno in rete. Anche in questo caso un sano spirito critico e una verifica oculata delle informazioni è sempre da preferire.
Ricordiamoci, quindi, sempre di rimanere aggiornati e consapevoli o, perlomeno, di provarci costantemente.
Del resto come ha scritto anni fa Albert Camus: “Un impiegatuccio in un ufficio postale è pari a un conquistatore, se la consapevolezza è comune a entrambi”.